
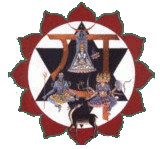 |
Associazione
Centro Yoga Anahata
Via Scalabrini 19/21 (Ospizi Civili), 29122 Piacenza http://www.centroanahata.org ............e-mail: info@centroanahata.org contatti: .339 270 9918 (cell. Silvia) - 0523 336715 (segr. tel.) |
 |
Raja Yoga
Il raja yoga
(yoga regale, nel senso del più elevato), consiste in una
serie di pratiche etiche e morali, asana
(posizioni immobili), pranayama (dominio del
respiro), tecniche di ritrazione dei sensi e
diversi livelli di concentrazione, fino al samadhi
(profondissima meditazione). Esso venne formalizzato in un
sistema coerente dal saggio Patanjali intorno ai primi secoli
dell'era cristiana, ma le radici di questa visione è
certamente più antico. Come per molti autori indiani, la
figura di Patanjali è piuttosto oscura e si presume che sia
vissuto tra il II sec. a.c. e il IV sec d.c. Il testo che
compose, gli "Yoga sutra" (aforismi dello yoga),
riassumono in 196 versi la sintesi dello yoga. Gli Yoga
sutra si dividono in 4 libri: 1) Samadhi pada
(libro dell'enstasi): nel primo libro ci si
occupa della natura generale dello yoga e delle sue tecniche e
risponde alla domanda fondametale: "che cos'è lo yoga?". E
poichè la tecnica essenziale e più elevata dello yoga è il samadhi
o enstasi (un neologimo creato da Eliade), ne espone una
trattazione accurata. 1) Samadhi pada
(libro dell'enstasi): nel primo libro ci si
occupa della natura generale dello yoga e delle sue tecniche e
risponde alla domanda fondametale: "che cos'è lo yoga?". E
poichè la tecnica essenziale e più elevata dello yoga è il samadhi
o enstasi (un neologimo creato da Eliade), ne espone una
trattazione accurata.2) Sadhana Pada (libro della pratica): nella prima parte del libro tratta dei klesa (le afflizioni, dolori, miserie della vita) e fornisce un quadro estremamente chiaro delle condizioni della vita e della miseria umana e risponde alla domanda: "perchè è necessario praticare lo yoga?". La seconda parte invece fornisce delle tecniche basilari dello yoga, ovvero yama (astensioni), niyama (pratiche di dissciplina individuale), delle siddhi (i poteri che queste pratiche comportano), le asana (posture del corpo), il pranayama (dominio del respiro), il pratyahara (la ritrazione dei sensi). 3) Vibhuti Pada: nella prima parte di questo libro vengono trattate le ultime tre pratiche dello yoga (antaranga, interiori): dharana (concentrazone), dhyana (contemplazione), samadhi (enstasi); nella seconda parte si tratta dei poteri (siddhi) che queste pratiche comportano. 4) Kaivalya Pada: nell'utima sezione degli aforismi si trattano brevemente ma sistematicamente i problemi filosofici legati alla pratica dello yoga: la natura della mente e della percezione, del desiderio e del suo effetto, la liberazione. Tutti questi temi tendono a raggiungere il kaivalya, l'isolamento spirituale in cui si risolve l'errore fondamentale, la commistione tra prakriti (materia) e purusha (spirito). Da queste poche righe si può immediatamente capire che lo scopo del raya yoga non è il raggiungimento di un benessere psicofisico oppure l'adattarsi alle avverse condizioni in cui siamo costretti a vivere. La sua meta è nobile ed altissima: comporta la liberazione da tutti i vincoli. Analizziamo ora nel dettaglio gli otto anga (membra) della pratica. Il termine stesso indica che questi "gradini" non devono essere necessariamente eseguiti di seguito in una scala rigida, ma che si può in qualche maniera iniziare un livello superiore prima di aver padroneggiato completamente quello precedente, senza tuttavia esagerare: è inutile tentare il samadhi se non si riesce a praticare yama! |
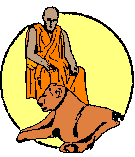 |
Yama: yama costituisce la base dello yoga: sono le vitrù sociali e devono essere portate ad un livello etico elevatissimo. Esse sono: ahimsa (non violenza), satya (veridicità), asteya (astensione dal furto), brahmacarya (continenza sessuale, assenza di desiderio), aparigraha (assenza di avidità, non attaccamento). Esse sono volte al negativo (non-violenza, non-attaccamento...), ma hanno un valore dinamico, positivo; quindi non solo non violenza, ma amore per tutte le creature; non solo non attaccamento alle proprietà, ma condivisione dei propri beni... Il voto dello yogin di non infrangere mai questi precetti si chiama maha-vrata, e ha un valore assoluto e indissolubile. | |
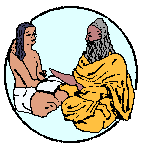 |
Niyama: sono regole individuali e costruttive: se uno yogin che si ritira dal mondo non ha modo di praticare yama, esso non può esimersi da niyama. I precetti sono: sauca (purezza), samtosa (appagamento), austerità (tapa), svadyaya (studio di sè), Isvara-pranidhana (abbandono a Dio). Le ultime tre pratiche costituiscono anche il kryia yoga o yoga preliminare. Isvara-pranidhana è anche una via indipendente che conduce al samadhi. Queste pratiche forgiano il cuore e la mente dello aspirante yogin e lo preparano alla via impervia dello yoga. | |
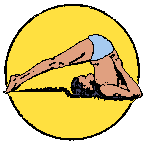 |
Asana: ecco forse la fase più popolare dello yoga (insieme alla meditazione). Asana significa "senza movimento". Lo yogin assume una posizione immobile che mantiene per un tempo variabile, via via più lungo. Lo scopo della asana nel raja yoga hanno lo scopo di mantenere il corpo sano e di permettergli di mantenere a suo agio posizioni meditative. Patanjali dice che l'asana deve essere "piacevole e corretta". Nello hatha yoga invece le asana hanno anche lo scopo di permettere all'adepto di sostenere la grande energia che la risalita di Kundalini provoca. | |
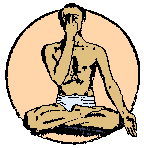 |
Pranayama: (controllo - o padronanza- del respiro). La traduzione è solo parzialmente corretta: il respiro è solo l'aspetto più evidente del processo, ma quello più sottile ed importante è quello di controllare le energie del prana di cui il respiro è solo un veicolo. Non è tanto importante eseguire un respiro lungo (per quanto un respiro corretto sia importante nell'igiene del corpo), quanto piuttosto giungere ad un respiro sempre più lento, ponendo grande accento sul suo trattenimento (kumbakha). Il controllo del respiro aiuta inoltre a controllare l'instabilità della mente ed ha pure un innegabile valore simbolico. | |
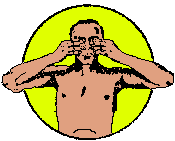 |
Pratyahara: dopo aver pacificato gli istinti più bassi, disciplinato la pratica, raggiunto il controllo del corpo e del respiro, si inizia una fase maggiormente introspettiva. Il praticante comincia a distaccarsi dalle fonti principali di disturbi: quelli esterni, frutto dei sensi e quelli interni, l'elaborazione di pensieri da parte della mente. Attraverso all'uso di varie tecniche (tra cui l'ascolto del respiro è una delle più importanti) si riporta l'attenzione verso il soggetto, tagliando sistematicamente le forme di distrazione. | |
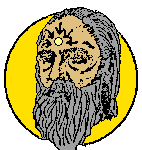 |
Dharana (concentrazione): con questo anga inizia il livello dello yoga superiore o interno, in quanto tutti i processi che si manifestano sono interni alla mente. Lo yogin inizia a concentrare la sua attenzione su un oggetto di meditazione, che in questa prima fase può essere di qualsiasi genere. Permane una netta distinzione mentale tra il soggetto (chi medita) e l'oggetto (l'oggetto della meditazione). In dharana ci possono essere ancora delle distrazioni, ma quando esse giungono al livello di coscienza, il praticante riporta l'attenzione sull'oggetto della meditazione. | |
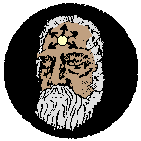 |
Dhyana
(contemplazione): Il passaggio tra dharana e
dhyana non è un salto brusco: dopo aver dominato completamente
le distrazioni in dharana e fissato completamente l'attenzione
sull'oggetto, nell'adepto comincia a dissolversi
l'autocoscienza, ovvero la distinzione tra oggetto e soggetto.
Vi è come un'espansione progressiva della coscienza. |
|
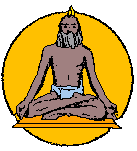 |
Samadhi (enstasi): quando sia le distrazioni che l'autocoscienza sono completamente placate, allora si raggiunge il samadhi. Patanjali descrive minuziosamente diversi livelli di samadhi: sabja (con seme); nirbjia (senza seme), megadharma... Quando lo yogin ha superato ogni attaccamento, anche ai poteri che il samadhi gli offre, allora diverrà completamente libero da ogni legame e raggiungerà finalmente il kaivalya, il supremo distacco in cui, come dice Patanjali, c'è "eguale purezza tra il sattva e il purusha". Lo yogin diventa un jiva mukhti, un liberato vivente. Il ciclo del samsara e delle rinascite è finalmente infranto. |




